Diritti e doveri: questione fuori registro
Il più delle volte si dice così: “Questo è un mio diritto!”. Quasi mai: “Questo è un mio dovere!”. Si procede “diritto” un po’ dappertutto. Nelle piccole come nelle grandi cose della vita. Ecco il racconto assai istruttivo di un prof. iniziato in classe e proseguito in una gita a Firenze. Tutto come previsto? Mica tanto…
10 maggio 2024
Lezione scivolosa
di Paolo Covassi

Prima scena. Aula di un istituto tecnico della provincia milanese, ora di italiano.
“Ragazzi, come sapete oggi inizio a interrogare… ci sono volontari?”
“…”
“Nessuno?”
“…”
“Allora chiamo io”
Agitazione. Qualcuno propone come volontario il proprio vicino di banco, il rappresentante di classe propone timidamente di rimandare, alcuni invitano una ragazza in prima fila a offrirsi facendo intendere, neanche troppo velatamente, che tanto qualcosa sa e, soprattutto, che non rischia di prendere un brutto voto data la mia presunta preferenza nei suoi confronti. Alcuni cercano di sapere almeno su quale argomento potrebbe essere l’interrogazione e sia le domande che le risposte mi fanno capire che sono messi male. Molto male. Inspiro con decisione pronto a partire col pippotto mensile su quanto sia importante studiare di volta in volta ecc. ecc. Ma è la prima ora, se io non ho voglia di parlare figuriamoci quanta ne hanno loro di ascoltare. Così al termine della mia lunga inspirazione che sembra aver assorbito anche tutto il loro chiacchiericcio, mentre mi alzo dalla cattedra espiro il fatidico “allora chiamo io”.
“Prof. Estragga!”
Se c’è una cosa che hanno imparato in questi anni dagli antichi greci è l’idea dell’ineluttabilità del fato e dell’inutilità di opporsi alla fortuna avversa, mentre i riti scaramantici li hanno appresi con la pratica nel tempo.
“Prof. estragga!” Evidentemente prendersela con il destino è meglio che pensare di essere stati scelti quali vittime sacrificali e io, un po’ vigliaccamente, accetto. In fondo va bene anche a me delegare le colpe alla sorte. Che poi, bastava che studiassero o almeno si mettessero d’accordo per trovare dei volontari. Ma come disse qualcuno che rischiava più di un brutto voto: “alea iacta est”.
Ovviamente l’estrazione avviene tramite apposito sito e trasmessa via Lim (lavagna interattiva multimediale) perché fidarsi di un prof in questi momenti non è cosa.
Per sicurezza estraggo quattro numeri accompagnati da molti sospiri e un paio di imprecazioni che faccio finta di non sentire. Il primo estratto è assente; il secondo è un ramingo (= studente che ad aprile sa già che per lui l’anno è segnato ma viene a scuola lo stesso perché così vede gli amici e i genitori non rompono) che dal fondo dell’aula esprime il suo dissenso con un “non se ne parla proprio” prima di ripiombare con la testa sul banco; il terzo è Lorenzo, un ragazzo con delle difficoltà e che ha diritto, tra le altre cose, ad avere le interrogazioni programmate. Quindi si passa al quarto, Federico, il sindacalista della classe (ce n’è sempre almeno uno) che, alzandosi per dare ancora più enfasi al suo discorso erompe con un tonante “non è giusto!”
Il primo pensiero è: ma tra tutti i numeri che potevano uscire, proprio questi due? La prossima volta chiamo io, ecco cosa succede a sottrarsi alle proprie responsabilità (il pensiero in realtà non è né così lucido né tanto meno così forbito, ma ci siamo capiti). Il secondo pensiero è: posso tornare indietro nel tempo e dire che oggi non interrogo? Il terzo, che si trasforma in parola, è una domanda: “perché non è giusto? Cosa non è giusto? Avete detto di estrarre, ho estratto…
“Non è giusto perché è uscito lui prima!” indicando il compagno che, evidentemente, non va proprio fiero della sua condizione.
“Ma lui ha diritto ad avere le interrogazioni programmate” rispondo pensando, illuso, di porre fine alla conversazione. Ma con mia grande sorpresa diversi altri intervengono a sostegno del sindacalista. Quella che segue è una discussione che mi sembra talmente surreale che non riesco quasi a intervenire. Questi ragazzi non sono solo compagni, sono anche amici tra di loro, eppure non si fanno problemi a definire il diritto del compagno a un trattamento che tenga conto delle sue difficoltà una “ingiustizia”. Sono basito e confuso, disorientato dai tanti che parlano tutti insieme ma tutti concordi nel “condannare” il compagno.
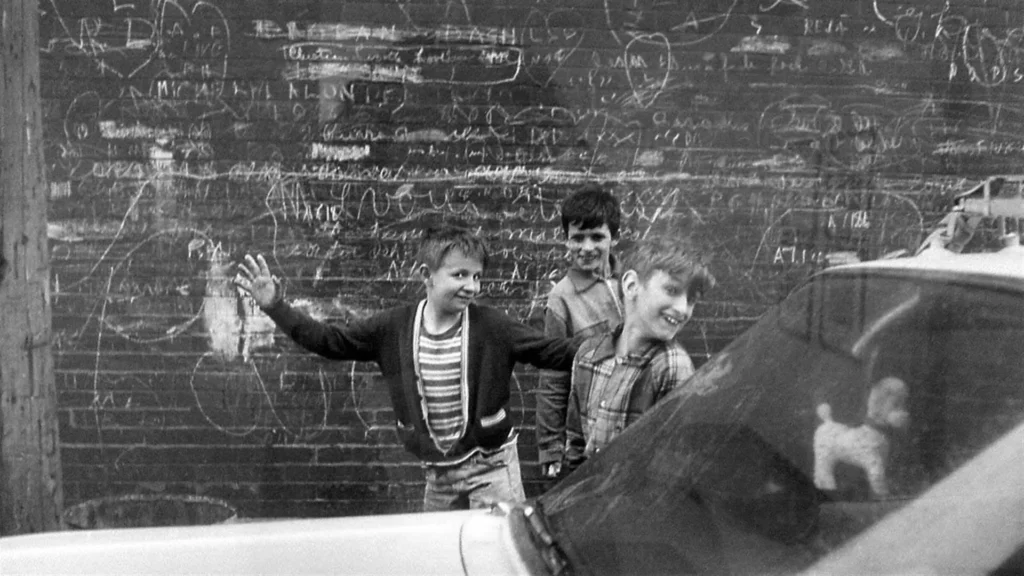
“Sì, però sta cosa…”
Alzo la voce, mi rifugio nella normativa, ma ovviamente ai loro occhi la norma è sbagliata. Devo trovare il modo di difendere il compagno senza calcare troppo la mano sulle sue difficoltà (che per altro sono piuttosto evidenti) ma non è facile. Alla fine ottengo il silenzio con un “ma stiamo scherzando!?!” che non lascia spazio a interpretazioni. Qualcuno si rende conto subito dell’assurdità della discussione, altri, sindacalista in testa, si ostinano a difendere la loro posizione.
Argomentare con chi difende il proprio interesse e non la giustezza della propria posizione non è per niente facile, anzi, inoltre vedo il povero Lorenzo sempre più in difficoltà tanto che arriva a promettere che si offrirà volontario la prossima volta. Ma non c’è niente da fare, per Federico e un paio di irriducibili giustizia significa essere trattati tutti allo stesso modo, io cerco di dimostrare che invece la giustizia è garantire a tutti le stesse possibilità. Più i ragazzi capiscono il mio punto di vista, più il sindacalista si irrigidisce sulle sue posizioni, così provo con un esempio.
“Tra qualche settimana andiamo in gita. Immaginiamo che un vostro compagno non possa venire perché non ha disponibilità economica, così chiedo a ciascuno di voi di versare dieci euro in più per permettere al compagno in difficoltà di partire con noi. Cosa dici Federico?”
“Dico che non sarebbe giusto” risponde coerente con il suo ragionamento.
“E se quello studente in difficoltà fossi tu?”
“Sarebbe giusto che me ne stessi a casa. Anzi, sarei io a dire che non è giusto che gli altri paghino per me”.
Capisco dagli ondeggiamenti delle teste che ormai Federico ne ha fatto una questione di principio, non c’è verso di fargli cambiare idea.
“Tornando al nostro caso – aggiungo – premesso che ormai l’ora è finita e quindi anche tu non verrai interrogato, ma non pensi che prima di parlare dei diritti veri o presunti tuoi o dei tuoi compagni avresti dovuto rispondere al tuo dovere, cioè studiare?”
Al suono della campanella raggiungo Federico in corridoio: “Ti rendi conto che con il tuo discorso hai messo in difficoltà Lorenzo? Hai mai provato a pensare come si deve sentire lui? Forse, prima ancora di parlare astrattamente di diritti e doveri, dovremmo cercare di capire qual è la cosa migliore per noi e per quelli che ci stanno vicini. O no?”
“Boh prof, “since” non saprei. Io so che loro se ne stanno tranquilli mentre noi veniamo sempre chiamati…”
“Quelli, come li chiami tu, credo che farebbero volentieri cambio. Ma poi scusa, Lorenzo non è tuo amico?”
“Sì, però sta cosa… boh, continuo a pensare che non sia giusto”

“Questo posto è uno spettacolo”
Seconda scena. Qualche settimana dopo. Classe di un istituto tecnico in gita, Firenze, Palazzo Vecchio, Sala dei Cinquecento.
La mattina è iniziata in salita. Dopo la prima notte in albergo, non proprio tranquilla, alle 8.15 del mattino eravamo all’ingresso del museo del Bargello. Ore 11 ingresso a Palazzo Vecchio e, nel pomeriggio, ci aspettano gli Uffizi. Più che un viaggio d’istruzione una maratona distruzione.
Dopo aver spiegato sommariamente la Sala dei Cinquecento mi viene incontro Federico, il sindacalista: “Prof (e già mi metto sulla difensiva temendo invettive contro i fiorentini che manco Dante all’inferno) mi sono innamorato”
Mi guardo in giro cercando la fanciulla di turno, ma lui mi precede: “Ma che bellezza è? Questo posto è uno spettacolo! Mi sono innamorato di Firenze”.
Si guarda in giro con uno sguardo che non gli ho mai visto e aggiunge: “Che spettacolo. Sa prof, ci ho pensato su e ora devo dire che aveva proprio ragione”.
“Certo che avevo ragione. Ma a cosa ti riferisci di preciso?”
“Alla questione delle interrogazioni, cioè, su quello ancora ho qualche dubbio, però si ricorda l’esempio della gita? Se qualcuno si fosse perso tutto questo perché non se lo poteva permettere sarebbe stata una vera ingiustizia. Forse se capissimo che è nostro dovere aiutare chi fa fatica non servirebbero certi diritti. Non so se si capisce”
“Certo, si capisce molto bene. Anzi, come lo hai detto tu è ancora meglio”
“Prof però ora sono preoccupato”
“Di cosa?”
“Siamo d’accordo su una cosa” e se ne va sghignazzando
“Tranquillo, sono sicuro che troverai qualcos’altro su cui discutere!”



