Byung-Chul Han: il raccontare è diventato vittima del consumismo
Il nuovo libro del filosofo Byung-Chul Hanintitolato “La crisi della narrazione. Informazione, politica e vita quotidiana” (Einaudi)” mette il dito nella piaga: il raccontare è diventato vittima del consumismo. E qui vi sono echi del miglior Pasolini. Oggi si tracima nello slogan pubblicitario. Nello storytelling dove tutto è vendita. In quella scelta unicamente mercantile viene così a mancare il momento di verità interno che lo libera. Perché sfugge la realtà. E questo strappo è causa dell’affermazione dell’individuo che non sa più ascoltare. Che certifica, in un presente prigioniero della finzione, la sopraggiunta dipartita della comunità umana. Sentenza definitva? No. Si può uscire dalla sola lucida analisi di questa malattia. Recuperando un significato del narrare per davvero “reale” nella vita di tutti i giorni. E a tutti i livelli della “comunità umana”.
8 marzo 2024
Una strada alternativa
di Alessandro Banfi
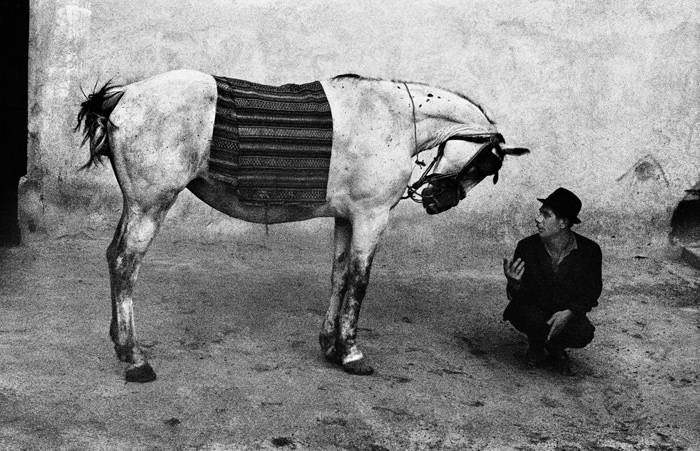
Il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni si è infuriata con i suoi per la “narrazione”. Non si è arrabbiata con i poliziotti che hanno usato i manganelli contro gli studenti di Pisa, studenti che manifestando a favore della Palestina non avevano né caschi, né mazze, né altri corpi contundenti. Si è preoccupata per l’immagine percepita.
Scriveva qualche giorno fa, nella cronaca del 27 febbraio, Angelo Picariello su Avvenire: «La premier ha sottolineato che occorre comunicare in modo corretto, che non ci si può lasciare sopraffare da una narrazione falsa. Perché, ha sostenuto, «l’esecutivo ha consentito sempre la libertà di espressione». Se c’è qualcuno che ha sbagliato «va individuato e sanzionato ma non si può passare dalla parte del torto. La sinistra – ha ragionato la premier – ci attacca? Piuttosto ci spieghi le regole di ingaggio. Dobbiamo o no difendere i siti sensibili? Dobbiamo o no proteggere gli agenti delle forze di polizia?» Per cui, «non c’è da chiedere scusa ma raccontare bene i fatti e che questo governo non ha mai inteso reprimere la libertà di espressione».
Le virtù dello storytelling
È un piccolo episodio, per carità. Ma significativo. I politici e i leader di mezzo mondo parlano continuamente di “narrazione”. Vladimir Putin nella lunga intervista televisiva con il giornalista americano Tucker Carlson ha proposto la sua narrazione sull’Ucraina. Mentre la stampa ucraina ha parlato, in replica, di narrazione putiniana. Uno dei saggi più brillanti su di un politico italiano dell’ultima generazione, Matteo Renzi, non è di un politologo, né di un economista e neanche di un analista internazionale ma di un professore di Italianistica, Claudio Giunta (Essere #Matteo Renzi, edizioni Il Mulino, 2015). Renzi fece scoprire a tutti le virtù dello “storytelling” governativo con il suo protagonismo sui social e le slide nelle conferenze stampa di Palazzo Chigi.
Ora un brillante filosofo di origine coreana, Byung-Chul Han che studia da anni in Germania, ha pubblicato a Berlino un saggio (in Italia edito da Einaudi) che ha un titolo molto preciso: “La crisi della narrazione. Sottotitolo: Informazione, politica e vita quotidiana”. La tesi del brillante Byung-Chul (in Corea, come in Cina, il cognome precede il nome) è contro corrente: le narrazioni nella nostra società sarebbero in crisi da tempo.
Nonostante l’uso e l’abuso del termine, in realtà il raccontare è diventato davvero vittima del consumismo (il “potere omologante” denunciato già nei Settanta da Pier Paolo Pasolini). Non più strumenti per orientarsi nel mondo e per costruire il proprio itinerario, le storie sono asservite ad una logica di commercio, di vendita.
Sono ridotte, avrebbe detto Karl Marx nel suo “Il Capitale”, a merce.
Alessandro Baricco: La necessaria vibrazione del racconto
La poesia è diventata slogan pubblicitario. La trama e il colpo di scena (l’agnizione) sono finalizzati ad accumuli emotivi, senza più profondità. Le notizie e l’informazione non servono più a farsi un’opinione, a crearsi un proprio sapere («Deliberare per conoscere» diceva il presidente della Repubblica italiana del dopoguerra Luigi Einaudi o anche il “Knowing keeps us free” recitato da Tom Hanks nello spot del “Washington Post” durante il Superbowl del 2019) ma sono concepiti in un meccanismo di accalappiamento, di “click bait”, in un facile acchiappa-citrulli.
Nelle narrazioni manca ormai quasi sempre quello che il filosofo coreano chiama «il momento di verità interno», o quella che Alessandro Baricco, uno scrittore che si è tanto occupato di questo tema in “The Game” e non solo, chiama la ncessaria «vibrazione» del racconto. L’interesse è tutto rivolto a una tecnica.
Ciò che conta sono le regole di composizione che permettono di costruire il racconto.

Sfugge la realtà
C’è un gioco di parole che spiega in un lampo perché oggi la narrazione è diventata effimera ed inefficace. Lo storytelling è soprattutto uno storyselling: il cambio di una sola lettera nell’espressione inglese racconta la trasformazione presente.
Nelle strategie del marketing contemporaneo, come sostiene Byung-Chul, «ci troviamo a comprare, vendere, consumare racconti ed emozioni. Le storie vendono. Raccontare storie coincide con il vendere storie. E si perdono due coordinate: il tempo e la comunità narrativa».
Il finto presente
Il tempo manca perché tutto è confusamente sintonizzato sul presente. In un eterno presente. Devo dire che la mia personale esperienza di insegnante all’Università conferma questo giudizio: gli studenti di oggi stentano a comprendere la linea storica degli eventi, la loro successione, le relazioni che nella realtà crescono fra i diversi momenti della storia umana.
Nel ronzio di fondo dell’informazione non ci sono più gerarchie o grandezze, prima e dopo, fatti e opinioni. Spesso i miei studenti slittano sulle “leggi fascistissime del 1925-1926” che fra l’altro in Italia abolirono la libertà di stampa, introducendo la censura e la prigione per i giornalisti.
Non sanno spiegare il nesso con il sequestro e l’omicidio di Giacomo Matteotti e poi con l’articolo 21 della Costituzione italiana che i padri costituenti, compresi Moro, La Pira e Togliatti, vollero fissare dopo la caduta del Fascismo e la Liberazione.
Vivere in un finto perenne presente rende la storia piatta, insignificante, a tratti bislacca e inutile da conoscere.
Byung-Chul cita il calendario cristiano come esempio positivo di narrazione con un «momento verità interno». Scrive il filosofo: «Narrando la religione cristiana spazza via la contigenza. È una metanarrazione che cattura ogni aspetto della vita e le dà un ancoraggio all’essere».

L’abbandono della capacità di ascolto
La seconda mancanza è quella della comunità. Per Byung-Chul «la comunità narrativa è una comunità che resta in ascolto». Ma oggi l’ascolto, come ha notato recentemente papa Francesco in uno dei suoi messaggi sulla comunicazione sociale, è un’impresa di pochi, di pochissimi. ‘Stiamo perdendo’, ha detto Bergoglio, ‘la capacità di ascoltare chi abbiamo di fronte, sia nella trama normale dei rapporti quotidiani, sia nei dibattiti sui più importanti argomenti del vivere civile’. Ascoltare postula infatti un’apertura all’altro, un’immedesimazione, una fiducia.
Scrive il filosofo: «Il dono del restare in ascolto ci sta sempre più abbandonando. Noi produciamo noi stessi, ci spiamo a vicenda, anziché, dimenticando noi stessi, donarci ascolto e restare in ascolto l’uno dell’altro».
In un momento, per l’appunto, così oscuro e critico della storia mondiale, sul tema della comunità viene in mente l’interessante carteggio fra Albert Einstein e Sigmund Freud sul tema della guerra e della pace. La vicenda è nota ed è contenuta ora in un libro. Nel 1932 il grande fisico, scopritore della Relatività, scrive una lettera al fondatore della psicanalisi in cui è molto esplicito e diretto: «La domanda è: C’è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra?». Domanda preveggente visto che sette anni dopo inizierà la Seconda Guerra mondiale. Ebbene Freud nella articolata risposta ad Einstein dice fra l’altro che per evitare la guerra, esito di pulsioni animali, «la condizione ideale sarebbe naturalmente una comunità umana che avesse assoggettato la sua vita pulsionale alla dittatura della ragione».
Il senso del limite e del fine
Fa riflettere che la guerra torni fortemente in primo piano oggi, quando a mancare è proprio la “comunità umana”, distrutta e parcellizzata in tanti individui singoli che guardano un piccolo (o grande schermo) davanti a loro, anche durante un pranzo di famiglia o una cena fra fidanzati. La comunità incalza l’individuo, costringe ad una ricerca di senso, sveglia il senso del limite e del fine. Byun-Chul Han è formidabile nel descrivere l’epoca in cui viviamo. Più difficile semmai è indicare una strada alternativa, una via di fuga perché la nostra narrazione riacquisti senso e speranza.



