Alessandro Piperno: L’aria di famiglia è un vento potente
Si intitola “Aria di famiglia” (Mondadori, 2024) il nuovo romanzo dello scrittore e critico letterario. Protagonista è il professor Sacerdoti, ebreo, che nella vita ritiene di essersi ritagliato un rifugio sicuro. Ma gli incerti e la violenza conformista del politicamente corretto mandano all’aria quella convinzione. Che è la sola certezza perseguita da un uomo ancorato al suo relativismo culturale e morale. E poi, ecco invece l’imprevisto di un incontro indesiderato. Perché imposto. Che, lentamente, ne scalfisce il tran tran quotidiano. È l’anticipo, quello, di una storia che prende un’altra direzione. Una storia drammatica, vera, sorprendente. Dove si compie qualcosa che recupera i molti “qualcosa”.
24 maggio 2024
Inciampo benefico
di Walter Ottolenghi
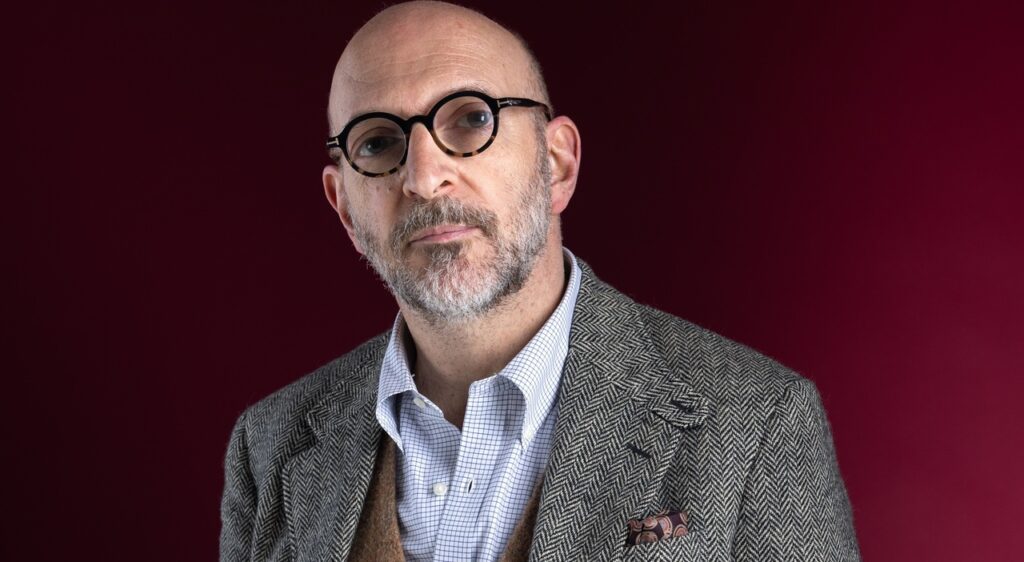
La stizzosa banalità del politically correct. O, meglio, la sconcertante noncuranza con cui un’umanità post-tutto, post-religiosa, post-liberale, post-industriale, post-filosofica ecc. ecc. soggiace passivamente non solo all’imposizione di nuovi dogmi ma anche dell’apparato repressivo che vigila sul loro rispetto. È questo il way point da cui inizia l’itinerario di un confuso professore di letteratura francese reo di avere citato a lezione alcune frasi di Flaubert dal contenuto misogino. Frasi che gli vengono, naturalmente, attribuite come sue da colleghe e colleghi tanto ignoranti quanto prevenute/i o semplicemente arrendevoli di fronte al nuovo conformismo predominante.
Poco conta che il prof. Sacerdoti pensasse di aver trovato nel suo relativismo culturale e morale un rifugio sicuro per proteggersi dalle intrusioni di scomode certezze. Per molti anni una calda coperta di conformismo adagiata nel tran-tran dell’ambiente accademico permeato dalla stessa accomodante mentalità e di una vita da agiato scapolo borghese svincolato da qualsiasi impegno con la serietà delle relazioni.
“Trovo i bambini tremendamente imbarazzanti” è una delle sue tante maldestre gaffes, per di più pronunciata in uno studio televisivo, rivelatrice peraltro della peculiarità del suo cinismo relativista, quella che gli stava tendendo un insidioso tranello. Come per molti relativismi anche il suo era tutto concentrato sul mantenere le dovute distanze dal già conosciuto, con la compiaciuta soddisfazione di chi vede nello specchio retrovisore la fila di lenti e pesanti camion superati in autostrada. Non poteva immaginare che attorno a lui di relativismo in relativismo fosse ormai sorto, come un inatteso diavoletto di Cartesio, lo spettro di una nuova intolleranza.
La citazione di Flaubert
Il nostro prof finisce senza rendersene conto nelle fauci del mostro che ha inconsapevolmente contribuito a creare. “Perché mi ha fatto passare?” “Boh… Abitudine? Educazione? Non saprei. Mi è venuto naturale”. “Le è venuto naturale perché io per lei non sono altro che questo: una matricola qualunque con cui fare il galante”. È talmente interdetto che arriva persino a chiederle scusa. Non lo sa, ma ha già la testa nella bocca del gatto.
La citazione di Flaubert e una serie di altri innocenti ma facilmente strumentalizzabili equivoci innescano una spirale persecutoria il cui esito è il suo stato di paria. Non solo la gogna mediatica che scatena schiere di haters sui social, ma anche la perdita dello stipendio e il crollo verticale delle vendite dei suoi libri. Ironicamente la prima offerta di riscatto economico proviene da un eccentrico mecenate in vena di avventure televisive che gli vuole affidare la sceneggiatura dell’improbabile serie Fanculo i maschi. “E’ un gesto politico”. Riflessione del prof: “Chissà perché, dopo un lungo letargo, la politica era tornata di moda, ma, per così dire, privata della sua nobile accezione aristotelica. Come se, di punto in bianco, si fosse appropriata di uno spazio semantico talmente vasto da contenere qualsiasi idiozia, persino una dissennata serie tv affidata a un romanziere alla canna del gas”.

L’ospite inatteso
L’incantesimo malefico di questo labirinto senza spiragli di uscita viene spezzato da un evento esterno e inatteso. L’affidamento di uno sconosciuto pronipote rimasto improvvisamente orfano che scompiglia il mazzo di una partita che sembrava ormai tutta giocata. Questo piccolo rappresentante della categoria dei tremendamente imbarazzanti si rivela in effetti l’inciampo che costringe a rimettere in movimento gli ingranaggi arrugginiti di una vita ormai scontata.
Non si tratta solo di passare dal ménage da scapolo di mezza età a una convivenza per di più a misura di bambino. Il nuovo ospite ha ricevuto un’educazione ebraica tradizionale ed è rispettoso dei precetti religiosi e delle regole del kasherut, incluse beninteso le restrizioni alimentari, e questo crea nel prof ulteriore sconcerto. Lo costringe però a riaprire controvoglia capitoli da tempo chiusi e dimenticati nel percorso di affrancamento da un’origine ingombrante.
“Are you Jewish? Aren’t you?” Ero ebreo? Forse sì, piccolo impiccione, o forse no. Di una sola cosa ero certo: non era stata ancora inventata la religione che mi avrebbe impedito di godermi un club sandwich. La questione si rivela un po’ più articolata di così. Diciamo che ci precipita nell’attualità di un momento storico in cui la pretesa di dividere l’umanità in categorie accettabili e categorie riprovevoli si ripresenta puntualmente con il suo bagaglio di volgarità e di violenza.
Dal “Fanculo maschio” al “Fanculo ebreo” il passo rischia di essere breve, così come il linciaggio morale contiene il germe di qualcosa di più spietato anche se provvisoriamente inconfessabile.
Un mondo in comune
È possibile chiamarsi fuori da queste spirali perverse? Forse sì o forse no. Anche perché la questione può non riguardare solo maschi o ebrei. In un’umanità troppo spesso in balia del ‘lato oscuro della forza’ chiunque può trovarsi inaspettatamente iscritto d’ufficio nella categoria degli sgraditi ai disegni del diabolico potere di turno. Come molti ebrei secolarizzati anche il prof riteneva che avendo tagliato i ponti con la religione si fosse anche affrancato dal peso di un’impegnativa eredità storica.
Senonché l’intrusione del piccolo Noah nel suo mondo ravviva il senso delle parole che il vecchio zio Gianni ripeteva a mo’ di memento al giovane prof: “Non serve credere in Dio per essere un buon ebreo”. Già, l’unità della famiglia è un fattore più dirimente e qualificante. Come dire, il solo modo per tenere in piedi una famiglia è stiparla di simboli, ricorrenze e consuetudini. E per quanto microscopica e artificiosa potesse apparire agli altri, quella formata da Noah e da me era una famiglia… anche e soprattutto perché avevamo in comune un mondo. Per quanto lugubre sembrasse, a unirci erano i morti. Il peso insostenibile della Storia, il sangue, le radici, gli atavismi. Insomma, l’ineludibile dannazione del DNA.
Da qui i tentativi di saldare la familiarità cercando goffamente di recuperare la ritualità domestica di festività e celebrazioni. Tentativi tanto tenaci da provocare nell’agnostico prof un inspiegabile fastidio quando il ragazzino annuncia l’impegno per una partita serale di calcetto prevista in coincidenza con l’inizio di uno shabbat. Nessun riavvicinamento alla fede dei padri, non sia mai detto, ma il recupero di un modo di vivere le relazioni con le persone più vicine mettendo in gioco un senso più profondo dell’incontro tra l’io e il tu.
Più prezioso perché ricevuto gratuitamente come l’eredità di un parente lontano, da un mondo che affonda le radici nella profondità del tempo, che viene da prima che l’io e il tu fossero. Che Noah fosse la mia famiglia, e io la sua, lo capii quando Valentina mi disse: ‘Vuole che ci sposiamo’. ‘E perché dovrebbe volerlo?’ Escludevo che Noah potesse sapere che io e Valentina eravamo andati a letto insieme”.
Già, perché, allora? Il vecchio scapolo glissa sulla domanda con uno scampolo di umorismo dal tono yiddish: “… mi sa che ha capito che sei un ottimo partito”. La faccenda, naturalmente, muore lì. Rivela però quanto il legame tra Noah e il prozio sia cresciuto al punto di esigere un ‘per sempre’. Un senso di definitività che emerge in occasione delle crude cronache dell’attualità. Adesso lo sai anche tu: una cosa è sentir parlare degli ebrei trucidati più di mezzo secolo fa, un’altra è vederli massacrati in diretta tv. … D’un tratto il teleschermo fu invaso dal primo piano di una ragazza che pregava il fidanzato di salvarla dai rapitori. Che ne sarebbe stato di lei? … Fu allora che la mano di Noah cercò la mia. Lo lasciai fare, naturalmente. Se eravamo una famiglia, e tutto congiurava a farcelo credere, quella ragazza ne faceva parte.

Misantropia e frustazione
Ma la famiglia ha anche i suoi inconvenienti. Il professor Sacerdoti e Noah Meisner se ne rendono conto una volta richiamati in Inghilterra per il lutto del vecchio nonno Leonard. L’esordio non è dei migliori, con una cena dai vecchi zii Baumann dove viene servito il peggio del kosher britannico. Mangiando di malavoglia notai due cose: che i coniugi Baumann benedicevano il piatto ogni volta che lo riempivano, e che si scambiavano fugaci sguardi di riprovazione ogni volta che Noah e io non lo facevamo. Fottetevi, pensai. Lo avete lasciato a me, scordatevi che ne faccia un fondamentalista del cazzo.
Ma li aspetta di ben peggio. Scoperto che il vecchio Meisner li ha tagliati fuori dal testamento lasciando tutto il suo ingente patrimonio al nipotino, i Baumann ingaggiano una feroce battaglia legale per accaparrarsi affidamento e tutela del ragazzino che quattro anni prima avevano rifiutato. Un colpo basso al quale il prof non riesce a reagire con la dovuta energia. Un po’ per la preoccupazione di mettere Noah al centro di una disputa davanti ai tribunali inglesi che rischiava di lasciarlo in uno stato di totale incertezza per molti anni. Un po’ perché riemergono vecchi aspetti della sua indole, non certo quella di un lottatore.
Il ritorno solitario a Roma lo precipita nella vecchia insensata spirale di misantropia e frustrazione, in un girare a vuoto tra i ricordi e la ricerca di un senso a quanto accaduto che però fatica a farsi largo tra i fantasmi dell’andropausa e della depressione evidentemente incipiente. Finché, dopo tanto inquieto vagare per la casa piena di ricordi e di rimorsi si ritrova alla tastiera del computer. … riempire il silenzio della notte con il ticchettio nervoso e sincopato dei polpastrelli sulla tastiera era un atto di sopravvivenza, una sfida all’ignoto, un argine contro la follia. Scrivere per far tornare i conti? Che sciocchezza! E allora per quale altro scopo?… Avevo rimesso in piedi la baracca, già questo bastava a rasserenarmi, per il resto meglio andarci piano e attendere giorni migliori. Ed è proprio il fare i conti con la parabola dell’esperienza appena conclusa che gli fa ritrovare la vena creativa. Per quanto mi turbasse ammetterlo, le famiglie erano il luogo privilegiato della farsa che mi aveva forgiato. Per questo erano così interessanti.
Fine della storia? Non proprio. Il finale a sorpresa non manca, ma bisogna meritarselo leggendo il romanzo fino in fondo.

Le paure non incrinano le relazioni
Le domande poste da questa lettura piacevole e anche divertente vanno comunque oltre i confini del contesto ebraico che le ha generate. On est toujours le juif de quelqu’un, si è sempre l’ebreo di qualcuno. La citazione di Gilbert Sinoué si riferisce al fatto che chiunque di noi può un giorno trovarsi assimilato a una categoria di vittime designate dal pregiudizio della follia di turno. Vero che è cosa diversa trovarsi di fronte a pericoli più o meno ipotetici oppure partire dalla certezza storica di discriminazioni e persecuzioni millenarie. Sta di fatto che comunque avere delle chiare radici culturali, etniche o religiose è un fattore di rischio sempre più frequente nella turbinosa accelerazione dei fenomeni di inasprimento delle relazioni politiche o anche solo culturali nella società contemporanea. Mimetizzarsi non basta per schivare i colpi. Al nostro protagonista non sono bastati gli scudi dall’agnosticismo e del relativismo per sottrarsi alla damnatio morale e materiale da parte delle nuove intolleranze. Talmente impreviste dal suo orizzonte conoscitivo da non avere la minima idea di come comportarsi per mitigarne l’intemperanza. Finendo, senza rendersene conto, per infilare una scivolata dietro l’altra in un declino che lo porterà alla rovina.
Riscoprire, poi, che la candidatura a un possibile annientamento sta addirittura irrimediabilmente inscritta nel proprio DNA marca la traccia di un’angoscia atavica e indelebile. Se la famiglia è il luogo dove questa angoscia è inevitabilmente trasmessa è anche il luogo dove può essere in qualche modo ricondotta a un senso. Certo non la famiglia bigotta e rapace dei Baumann. Ma non necessariamente inappuntabile per virtù e buone maniere. Anche una famiglia formata da uno zio un po’ scapestrato e rintronato e da un nipote perfettino può funzionare. Se l’affetto e il desiderio di condivisione sono forti le paure non riescono a incrinare le relazioni. Anzi, la consapevolezza di una storia di dolori tramandata e lasciata alle spalle può diventare un cemento di unità potente, fondativo.
E poi, soprattutto, può essere il luogo di una tenerezza che tutto consola. Mi rannicchiai nella chaise-longue come un bimbo assonnato. L’ultima cosa che vidi prima di assopirmi fu un’ombra con gli occhi di mia madre. Fu lei, quell’ombra amorevole, ad avvolgermi in un plaid.



