Le tentazioni diaboliche dei sistemi finanziari
Bolle speculative e fallimenti bancari
Il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Semplificando, ma non troppo, le crisi finanziarie affondano nella verità di quel detto popolare. Le banche non sono il problema in quanto banche, infatti le hanno inventate i francescani a metà del ‘400. Lo diventano quando cedono all’insidia di un nemico molto ma molto agguerrito e affascinante. A patirne gli esiti i risparmiatori. Oggi come ieri. E l’altro ieri. L’illuminante monito del cardinale Angelo Scola.
21 aprile 2023
di Gianfranco Fabi
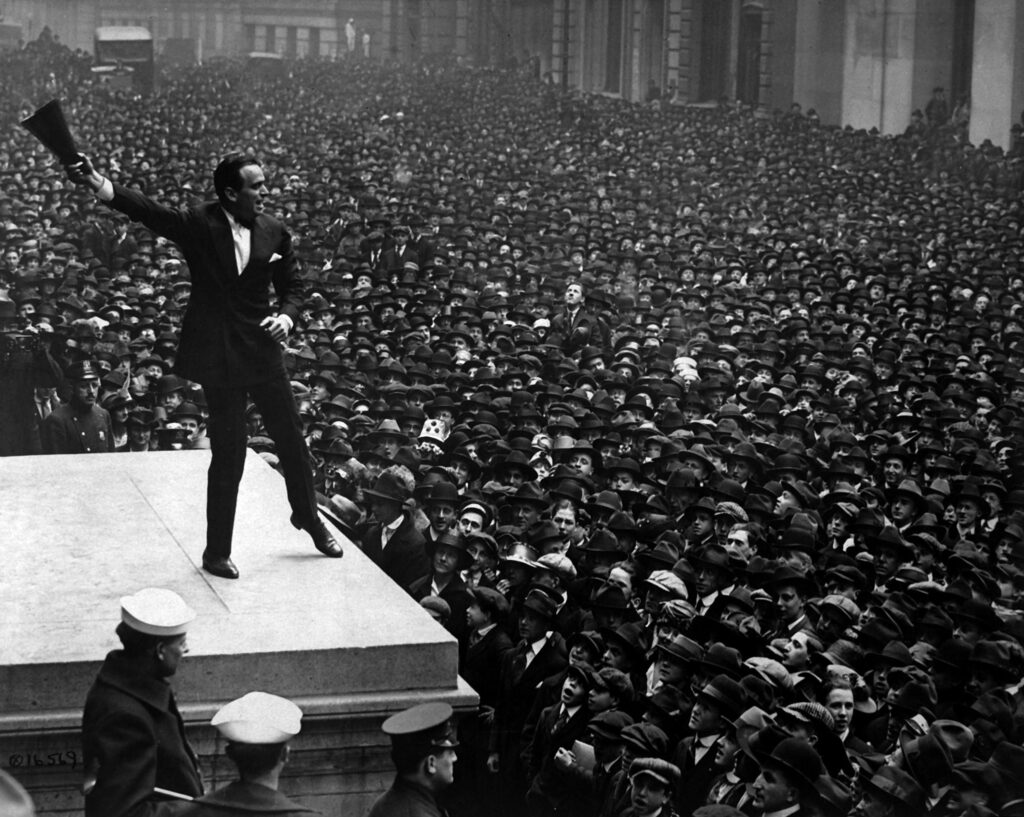
«Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; avresti potuto affidare il mio denaro ai banchieri e, così, ritornando, avrei ritirato il mio con gli interessi» (Matteo, 25, 24). Al di là delle interpretazioni teologiche questa parabola dimostra almeno una cosa: i banchieri c’erano già ai tempi del Vangelo e facevano il loro mestiere.
Certo, la parabola dei talenti non va letta come un invito alla speculazione finanziaria o come una legittimazione del prestito con interessi, materia su cui per secoli si è animato quel dibattito tra economia e teologia che è stato risolto dai francescani a metà del ‘400 nella maniera più drastica: fondando una banca.
Anche se i banchieri, cioè chi presta soldi a chi ne ha bisogno, sono antichi quanto il mondo, la banca come istituzione è nata infatti sei secoli fa sposando i principi di solidarietà con le potenzialità del denaro e dei sistemi finanziari. Sono nati così i Monti di pietà e i monti frumentari per offrire un sostegno economico ad una agricoltura che rappresentava il fondamento dell’economia di quel periodo.
In questa dimensione lo stesso Monte dei Paschi di Siena considerata la più antica banca del mondo ha avuto origine nel 1472, come “Monte Pio”, per aiutare i poveri attraverso i proventi dell’attività creditizia. È forse interessante ricordare che l’attuale denominazione “dei Paschi” si deve a metà ‘600 al Granduca Ferdinando II di Toscana che concesse ai depositanti del Monte la garanzia dello Stato, vincolando le rendite dei pascoli demaniali della Maremma (i cosiddetti “Paschi”). E non è un caso che proprio la banca senese si specializzò nei secoli successivi, prima di diventare una controversa banca universale, proprio nel credito fondiario.

I fiori del male: la bolla dei tulipani
É invece una coincidenza del tutto casuale il fatto che proprio a metà Seicento sia esplosa quella che viene considerata la madre di tutte le crisi finanziarie: la bolla dei tulipani in Olanda, la prima incursione del diavolo nelle attività monetarie. Importati dalla Turchia i bulbi di tulipano diventarono prima una moda, per la bellezza del fiore, poi una rampa di lancio per la speculazione: la domanda superò presto la loro offerta e i prezzi salirono sempre di più, perdendo ogni contatto con la realtà. Si crearono allora i “future”: si potevano acquistare (e vendere) contratti che davano diritto all’acquisto di fiori futuri.
La spinta della domanda era talmente forte che uno dei bulbi più pregiati, il “Semper Augustus” venne venduto all’asta per l’equivalente di due anni di stipendio di un operaio. Il tutto fino al 5 febbraio del 1637 quando un’asta andó deserta e iniziò quello che da allora è stato chiamato “panic selling”, la corsa alla vendita, lo scoppio di quella bolla speculativa che avrebbe dovuto insegnare (ma non avvenne) che la tentazione di creare il denaro con il denaro non poteva che portare alla crisi e al fallimento.
Da allora le crisi finanziarie, nonostante tutto, hanno fatto costante compagnia alla storia della moneta e del credito.
Ogni volta con una giustificazione, ben sintetizzata nel titolo di un libro “Questa volta è diverso” di Carmen M Reinhart e Kenneth S. Rogoff, dove si mette in risalto come la memoria corta, da una parte, e la tentazione del guadagno dall’altra, abbiano continuato ad essere nei secoli due ingredienti ampiamente diffusi nella società.
La bolla dei tulipani è passata alla storia non solo per il suo rapido e clamoroso fallimento, ma anche perché diede inizio a quell’ingegneria finanziaria che ha moltiplicato gli strumenti a disposizione dei moderni alchimisti con l’eterna pretesa di trasformare i sassi in pepite d’oro. C’è un altro libro dal titolo significativo, scritto proprio in quell’epoca dall’ebreo portoghese, Joseph Penso de la Vega, che riparò in Olanda per sfuggire alla persecuzione religiosa in atto nel suo paese: “Confusion de Confusiones”, un dialogo tra un mercante, un filosofo e un azionista. L’immagine che esce è quella di un manicomio dove ognuno difende i propri interessi e la propria visione del mondo…. a prescindere dalle osservazioni dei suoi interlocutori.

L’intervento degli Stati
Da quegli anni il sistema finanziario non è cambiato, se non nel progressivo perfezionamento delle strategie manageriali e nell’adozione degli strumenti di elaborazione e trasmissione digitale dei dati. E in entrambi i fattori le tentazioni diaboliche hanno spesso avuto il sopravvento.
È stato così nel fallimento della Compagnia delle Indie come nella grande crisi del ‘29, una crisi quest’ultima che ha riprodotto lo schema di quattro secoli prima semplicemente sostituendo ai bulbi di tulipano i terreni per lo sviluppo residenziale della Florida (come spiega molto bene John K. Galbraith nel suo libro “Il grande crollo” del 1954).
Ed è stato così che lo zampino del diavolo ha fatto crollare nelle scorse settimane due castelli di carte mettendo a rischio tutto il sistema bancario e finanziario: la crisi della Silicon Valley Bank e quella del Credit Suisse. Due crisi parallele dove il diavolo è riuscito a trovare quella pietra angolare tolta la quale solo l’intervento degli Stati ha potuto evitare perdite colossali per i risparmiatori (perdite che comunque ci sono state) e soprattutto il diffondersi di ondate di panico che avrebbero potuto facilmente dare innesco a crisi sempre più gravi.
La ragione dei due crolli ha un solo nome: fiducia, ovvero la mancanza di fiducia. La Svb aveva ampliato i propri affari collocando una parte significativa della propria riserve in titoli di Stato a lungo termine, titoli che negli ultimi mesi avevano perso valore per la strategia di aumento dei tassi di interesse da parte della Banca centrale americana (Fed) e questa perdita di valore ha creato forti dubbi sulla possibilità della banca di onorare le promesse verso la clientela. Del tutto diverso il caso del Credit Suisse dove a costringere i dirigenti a gettare la spugna é stata l’ondata crescente di sfiducia verso una gestione temeraria con operazioni tutt’altro che trasparenti negli angoli più remoti del mondo.

“Il mercato non esiste in natura”
Nulla di nuovo sotto il sole. Dopo tutto, lo scandalo bancario dell’allora Credito svizzero di Chiasso nel 1977 aveva messo in luce la difficoltà di resistere alle tentazioni sul filo della legalità come a quel tempo avveniva sfruttando i trasferimenti di capitali dall’Italia alla Svizzera.
Si può allora concludere affermando che le crisi finanziarie siano dovute all’avidità dei banchieri, alla carenza dei controlli e alla debolezza delle regole? Oppure siano un esempio di quello che è chiamato il fallimento del mercato, l’incapacità strutturale del sistema economico e finanziario di utilizzare bene la libertà con la conseguente necessità di continui salvataggi da parte degli Stati e delle autorità?
Il dibattito è aperto, ma vale la pena di richiamare quello che affermava il cardinale Angelo Scola, parlando agli imprenditori da Arcivescovo di Milano: “Il mercato non esiste in natura, ma è stato realizzato dagli uomini e quindi nasce e si è sviluppato come elemento di cultura”. Questo vuol dire che come ogni struttura umana deve essere adeguato, sviluppato, modificato secondo i valori che ogni persona dovrebbe portare nella società. E tanto meglio se i valori sono quelli di solidarietà ed efficacia dei francescani del Quattrocento e se il richiamo della parabola dei talenti viene letto come un invito all’operosità, al non richiudersi in se stessi, ad aver fiducia negli altri, magari proprio nei banchieri. Satana permettendo, ovviamente.



